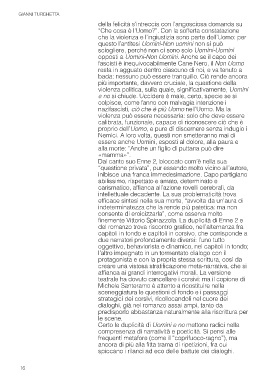Page 16 - UOMINI E NO - STAGIONE 2017-2018 - PICCOLO TEATRO MILANO
P. 16
UOMINI_E_NO_PROGR_DEF_21_10_15.30.qxp_2011 23/10/17 09:49 Pagina 16
GIANNI TURCHETTA
della felicità s’intreccia con l’angosciosa domanda su
“Che cosa è l’Uomo?”. Con la sofferta constatazione
che la violenza e l’ingiustizia sono parte dell’Uomo: per
questo l’antitesi Uomini-Non uomini non si può
sciogliere, perché non ci sono solo Uomini-Uomini
opposti a Uomini-Non Uomini. Anche se il capo dei
fascisti è inequivocabilmente Cane Nero, il Non Uomo
resta in agguato dentro ciascuno di noi, e va tenuto a
bada: nessuno può essere tranquillo. Ciò rende ancora
più importante, davvero cruciale, la questione della
violenza politica, sulla quale, significativamente, Uomini
e no si chiude. Uccidere è male, certo, specie se si
colpisce, come fanno con malvagia intenzione i
nazifascisti, ciò che è più Uomo nell’Uomo. Ma la
violenza può essere necessaria: solo che deve essere
calibrata, funzionale, capace di riconoscere ciò che è
proprio dell’Uomo, e pure di discernere senza indugio i
Nemici. A loro volta, questi non smetteranno mai di
essere anche Uomini, esposti al dolore, alla paura e
alla morte: “Anche un figlio di puttana può dire
«mamma»”.
Dal canto suo Enne 2, bloccato com’è nella sua
“questione privata”, pur essendo molto vicino all’autore,
inibisce una franca immedesimazione. Capo partigiano
abilissimo, rispettato e amato, determinato e
carismatico, affianca all’azione rovelli cerebrali, da
intellettuale decadente. La sua problematicità trova
efficace sintesi nella sua morte, “avvolta da un’aura di
indeterminatezza che la rende più patetica: ma non
consente di eroicizzarla”, come osserva molto
finemente Vittorio Spinazzola. La duplicità di Enne 2 e
del romanzo trova riscontro grafico, nell’alternanza fra
capitoli in tondo e capitoli in corsivo, che corrisponde a
due narratori profondamente diversi: l’uno tutto
oggettivo, behaviorista e dinamico, nei capitoli in tondo;
l’altro impegnato in un tormentato dialogo con il
protagonista e con la propria stessa scrittura, così da
creare una vistosa stratificazione meta-narrativa, che si
affianca ai grandi interrogativi morali. La versione
teatrale ha dovuto cancellare i corsivi: ma il copione di
Michele Santeramo è attento a ricostituire nella
sceneggiatura le questioni di fondo e i passaggi
strategici dei corsivi, ricollocandoli nel cuore dei
dialoghi, già nel romanzo assai ampi, tanto da
predisporlo abbastanza naturalmente alla riscrittura per
le scene.
Certo le duplicità di Uomini e no mettono radici nella
compresenza di narratività e poeticità. Si pensi alle
frequenti metafore (come il “coprifuoco-ragno”), ma
ancora di più alla fitta trama di ripetizioni, fra cui
spiccano i rilanci ad eco delle battute dei dialoghi.
16